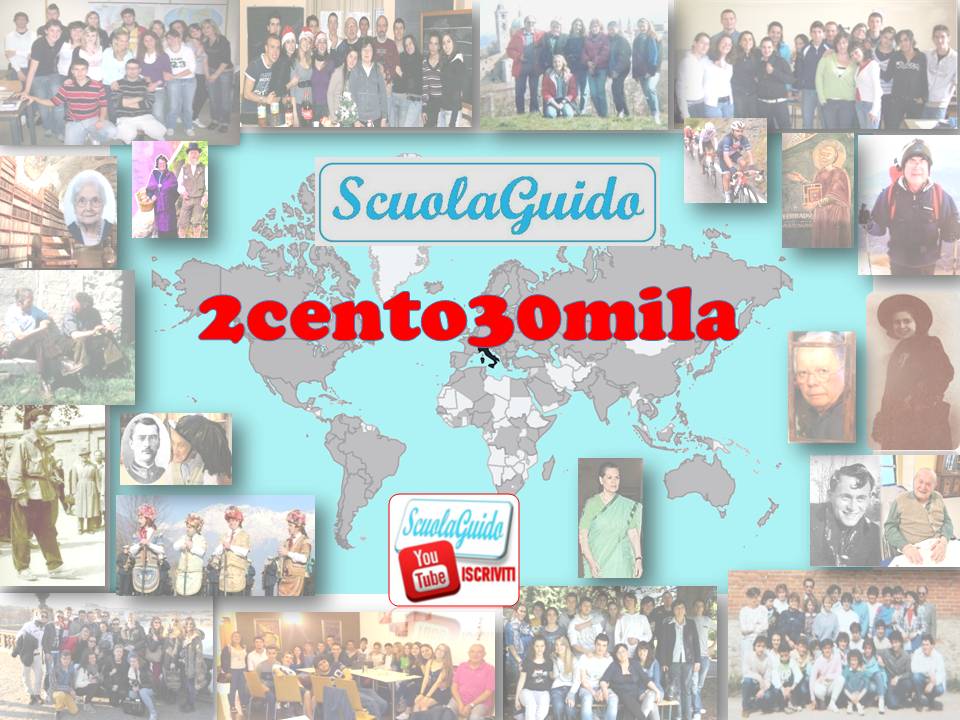Gita Unitre Giaveno Val Sangone, 21-23 ottobre 2022

Cominciamo dal “mondo piccolo” di Guareschi e Brescello
Per beffare il Covid l’Unitre Giaveno Val Sangone ha anticipato la gita annuale ad ottobre. Forse per vendetta, dopo mesi di siccità, siamo partiti sotto la pioggia, ma con temperature miti. 46 gitanti determinati, armati di trolley e buona volontà, un autista in gamba e un pullman comodo. Dopo poche ore siamo stati accolti dai luoghi di Guareschi in modo tradizionale: aria umida e nebbiolina sospesa su una pianura sconfinata. A pochi chilometri da Fontanelle, dove l’autore di “Don Camillo” è nato nel 1908, in una torre campanaria (sopravvissuta all’abbattimento della vicina chiesetta), con grande passione e determinazione Cesare Bertozzi, amico di famiglia dei Guareschi, con la moglie Caterina, ha allestito e gestisce un piccolo museo. Baffoni e lineamenti alla Giovannino, come un Guareschi redivivo ci ha raccontato il personaggio, la famiglia, i luoghi e le persone vere che ne hanno ispirato i racconti: Don Natale Bernini per Don Camillo e Giovanni Faraboli, sindacalista, per Peppone.
La finzione cinematografica ha trasportato le vicende dei due amici-nemici a Brescello, nel Reggiano, ma una grande mappa a muro associa gli scritti di Giovannino a questi luoghi, a partire dalla torre campanaria del museo e dal nome della località, “Boscaccio“, già presente nel primo dei racconti guareschiani, riferito al podere “Bosco” dove vissero i suoi nonni paterni.

La vicina Osteria Ardenga ci ha poi accolto con i profumi della sua cucina e della stanza di stagionatura, con le sue stalattiti di prosciutti, coppe e culatelli.
Un’oretta di pullman per digerire l’abbondanza di salumi e di primi del pranzo e siamo finiti nella location dei film. Brescello, con la sua piazza su cui si fronteggiano Chiesa e Municipio, incantò il regista francese Julien Duvivier e il paese, addormentato nella nebbia della “Bassa” salì alla ribalta. Qualche mal di pancia serpeggiava nei partiti, perché negli anni Cinquanta il clima politico era molto teso, ma la buona paga creava lunghe file all’ufficio di reclutamento delle comparse, dove “compagni” e clericali si mescolavano pazienti. L’entusiasmo della giovane guida ci ha portato davanti al crocefisso parlante, che aveva cinque teste intercambiabili per dare l’impressione del movimento, sotto la campanona che incapsulò Peppone, graziato dal furto del battaglio, e davanti al balcone da cui Peppone mostrò l’ultimogenito alla folla. L’episodio ha un riferimento reale e riguarda proprio Guareschi, nato il 1° maggio e mostrato dal sindacalista Faraboli alla folla di lavoratori come un nuovo compagno … le ultime parole famose. Sulla piazza, che riporta ancora le scritte in cirillico di quando era diventata il paese gemellato di Brezwyscewski nel film Il compagno don Camillo (girato da Comencini nel 1965), prospettano due musei che riprendono memorabilia dei film. Ce ne andiamo all’imbrunire tra le sagome della locomotiva e del carro armato, lasciando Peppone e Don Camillo a fronteggiarsi in piazza, con le loro facce di bronzo.
Ravenna: mosaici, mosaici e Dante
Notte tranquilla in una Milano Marittima da bassa stagione. Dormono il Gallia e il Papeete, dorme il mare invisibile oltre l’argine sabbioso che preserva le spiagge, dormiamo noi, in attesa del giorno più impegnativo. Dalla Costa Rica e dalla Russia arrivano le guide che con competenza ci portano alla scoperta della città dei mosaici. Mentre sulla decadenza dell’impero romano scorrevano i barbari, Ravenna, protetta dalle paludi e aperta al mare Adriatico e all’Oriente, diventava capitale. Teodorico, gli esarchi e i potenti vescovi eressero imponenti chiese, inconfondibili per i campanili cilindrici e per gli interni che ancora rilucono delle tessere cangianti dei mosaici. Nella penombra di San Vitale le pagliuzze d’oro imprigionate nella pasta vitrea disegnano i contorni delle aureole laiche di Giustiniano e della chiacchierata Teodora, nel suo mausoleo Galla Placidia, più volte sposa, non c’è e i mosaici e il cielo stellato sono solo per i visitatori, incalzati dal custode con l’orologio in mano.
Nel pomeriggio Sant’Apollinare Nuovo ci accoglie con le maestose processioni delle vergini e dei martiri e con le sue ambiguità. In tempi lontani, ma anche più recenti, scelte politiche e disinvolti restauratori hanno cancellato l’eretico Teodorico e manomesso altre figure: con disinvoltura le corone dei Re Magi sono state sostituite dal berretto frigio.
Dove è morto l’impero Romano d’Occidente è morto anche Dante, probabilmente di malaria, fiaccato da vent’anni di esilio. Il tempietto neoclassico che lo ospita ispira serenità, ma le spoglie del Poeta anche dopo la morte non hanno avuto pace, contese, trafugate, nascoste. I fiorentini che lo cacciarono in vita, non sono riusciti a riprenderselo in morte, ma ci hanno provato.

Sulla via del rientro in hotel, al calar del sole, un ultimo capolavoro ci attende. Vicino al porto di Classe, che in epoca romana era più grande di Ravenna, sul luogo del martirio del primo vescovo, Apollinare, la basilica più ampia e più spoglia. In una fuga di colonne variegate e volti sbiaditi d’antichi prelati, lo sguardo si concentra sull’abside. Sant’Apollinare predica nel verde, bianche pecore si muovono ordinate, simboli biblici ed evocatori si accavallano sotto il gesto pacato del Cristo benedicente e degli evangelisti. Un murmure di rosario sale da un gruppo di suore. Usciamo nel tramonto che langue tra i grossi pini marittimi e torniamo in hotel.
Il labirinto, le forme e il Parmigianino
Partiamo di buon’ora e con qualche apprensione, perché a Fontanellato ci aspetta “il Labirinto” della Masone. Le guide, che ci accompagnano tra l’eclettica collezione di Franco Maria Ricci, fanno poco per tranquillizzarci. Un braccialetto giallo col numero d’emergenza e laconiche istruzioni sono un misero conforto mentre ci addentriamo tra siepi e gallerie di migliaia di bambù, cercando di non disperderci troppo. Non c’è un Minotauro in agguato, ma dopo giravolte inquietanti e incroci di gente vagante troviamo il filo d’Arianna nei nostri telefonini e senza perdere nessuno saliamo in pullman per una tappa più allettante.

A Noceto ci accoglie il calore di una gestione familiare e la competenza di chi produce Parmigiano reggiano da generazioni, il Caseificio Corradi. Le forme che galleggiano in salamoia e quelle che incombono dagli alti ripiani della stagionatura, riempiono gli occhi. Poi la degustazione dei tre parmigiani, degli immancabili salumi e d’un allegro lambrusco riempie le bocche e attutisce il sapore di pollo che ha accompagnato i pasti precedenti.
Rifocillati e riforniti affrontiamo l’ultima visita, la Rocca di Fontanellato.


Maniero medievale, circondato dal fossato e difeso da quattro torri e un ponte levatoio, l’edificio è stato donato al Comune nel 1948 dall’ultimo dei Sanvitale, ed ora è metà municipio e metà museo. Le stanze sono rese cupe dal cotto, dai drappeggi, dalle panoplie d’armi e dal mobilio tra il rinascimentale e il barocco, ma la stanzetta affrescata dal Parmigianino è una gemma colorata. Il giovane pittore sviluppa nelle lunette e nelle vele della volta la metamorfosi di Atteone, mutato in cervo e sbranato dai cani, per aver visto Diana nuda. Senza perderci dietro alle discusse interpretazioni simboliche, ammiriamo in Cerere un’anticipazione della famosissima Madonna dal Collo Lungo, che sarà un simbolo del Manierismo postrinascimentale.


Rientriamo a Giaveno quando ormai è notte, stanchi perché sono stati giorni impegnativi, ma soddisfatti per le cose belle e buone che abbiamo visto e assaporato.